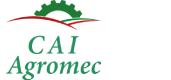Pubblicato

Da Nord a Sud, la competitività del sistema produttivo è in
crisi e se non si prenderanno misure più incisive, e risolutive,
alla fine dell’emergenza sanitaria farà seguito un lungo
periodo di recessione.
Il costo del lavoro è il principale fattore negativo e costituisce un
incentivo all’illegalità: dato che la maggior parte di esso è assorbito
da imposte e contributi, dei quali solo la metà servirà a garantire
la pensione al lavoratore, la differenza fra lordo e netto finisce per
premiare gli evasori. In altri paesi dell’Unione europea, anche quelli
che hanno un sistema previdenziale e fiscale simile al nostro, la
maggior parte del costo rimane nelle tasche del lavoratore, che
ha a disposizione un reddito effettivamente spendibile in grado –
ad emergenza finita – di rilanciare i consumi. In Italia, invece, è il
sistema produttivo a pagare le inefficienze dello Stato, col risultato
che più aumentano le differenze rispetto al lavoro irregolare, più
questo finisce per prosperare, specie dove la presenza statale è
labile o percepita come tale.
Ma gli oneri previdenziali non sono i soli protagonisti di questo
squilibrio, che coinvolge direttamente anche le imposte sui redditi:
come si può pensare di stimolare i consumi quando almeno un
quarto di ogni euro guadagnato deve andare allo Stato, anche con
redditi al di sotto della soglia di sopravvivenza? Quando si parla di
pressione fiscale bisogna poi considerare che nel prezzo di ogni
bene o di ogni merce che il privato cittadino deve acquistare per
vivere, sono comunque comprese varie imposte, a partire dall’Iva,
che incide – a seconda dei prodotti – per una percentuale che va
dal 4 al 22%.
E tutto ciò senza contare le accise, nascoste nei prezzi dei prodotti
energetici, dall’energia elettrica al metano, dai carburanti agli alcolici:
stupisce per esempio che anche quest’anno si siano registrate
le solite pressioni, in ambienti governativi, per aumentarle. Accise
che sono già elevatissime: sul gasolio destinato all’autotrazione
incidono per circa 61 centesimi al litro, esattamente il doppio del
costo industriale del carburante: una differenza talmente elevata
da alimentare un fiorente contrabbando dall’estero ed un’evasione
miliardaria. Il meccanismo è relativamente semplice e si fonda sul
diverso regime fiscale previsto per i lubrificanti; con l’aiuto di documenti
falsi il gasolio entra in Italia come “olio” e può quindi essere
smerciato tramite distributori compiacenti, che lo vendono insieme
al gasolio regolare, magari a prezzi stracciati.
Insieme all’aumento delle accise, poi, anche quest’anno si è parlato
di ridurre, se non di sopprimere, le agevolazioni sui carburanti
agricoli, un’iniziativa che Cai ha fortemente contrastato per i gravi
effetti che potrebbe determinare sul settore primario, già messo a
dura prova. La ricerca di facili entrate sui carburanti – i più tassati in
Europa – altro non fa che rendere più remunerativi questi traffici
che, oltre a sottrarre gettito allo Stato, richiedono un forte impegno
di risorse che potrebbero essere destinate al contrasto di tante altre
attività illecite. Se potessimo godere di un sistema fiscale più giusto
e più aderente a quello adottato dagli altri partner europei, l’Italia
potrebbe far valere il proprio immenso potenziale competitivo,
attraendo investimenti e insediamenti che invece dobbiamo mestamente
veder fuggire all’estero.
Le attività che ruotano attorno alla produzione agricola primaria
– che gode di un regime di tassazione simile a quello dei “paradisi
fiscali” – rendono ancor più stridenti questi contrasti.
L’imprenditore agromeccanico paga le imposte sul reddito d’impresa,
con un carico fiscale e contributivo totale che supera il 50%;
l’agricoltore paga molto meno della metà,con un’incidenza di
tasse e contributi che si riduce ulteriormente se svolge attività più
redditizie, come la produzione di energia.
Non sembra accettabile, né costituzionalmente legittimo, che
nell’ambito dello stesso settore produttivo due imprese così strettamente
legate si trovino a sopportare carichi tanto diversi.
Se queste iniquità servissero almeno ad aumentare la competitività
del settore agricolo, sarebbero più facili da tollerare; ma sembra
invece che accada il contrario. Ai tempi in cui l’agricoltore godeva
del solo vantaggio della tassazione catastale, dalle attività agricole
si ricavava un reddito accettabile, che consentiva di mantenere una
famiglia; oggi sembra quasi che aiuti, agevolazioni e facilitazioni
servano solo a controbilanciare, almeno in parte, le vessazioni
che il mercato può liberamente commettere nei confronti dei
produttori agricoli.
Un siffatto atteggiamento è figlio della deriva liberista che ha
contraddistinto le politiche agricole degli ultimi decenni: eppure,
fra gli ideali fondanti dell’Unione europea c’è proprio la convinzione
che la politica debba influenzare l’economia, e non subirla
passivamente.
Agevolare l’agricoltore rispetto ad altre categorie produttive, solo
perché non si vuole incidere sui mercati, sta portando al suo progressivo
impoverimento. Pagare poche tasse non serve a nulla
se non c’è guadagno: meglio pagare come gli altri ma lavorare
dignitosamente e vedere riconosciuto il frutto delle proprie fatiche.
• Gianni Dalla Bernardina
Presidente CAI