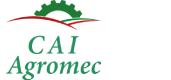Pubblicato

Il sistema agroalimentare sta subendo da qualche tempo una
doppia pressione mediatica, sulla quale sarebbe opportuno
condurre una riflessione. Da un lato la produzione agricola,
interpretata in una visione mediatica folcloristica (forse mai
esistita) e dall’altra la sua reale natura di scienza della vita,
fondata su tecniche produttive sofisticate ma troppo spesso,
immotivatamente, accusata di essere fonte di inquinamento
e di pericolo per la salute. Nella stessa filiera, ma su un altro
versante, l’industria di trasformazione, che strizza l’occhio alla
tipicità e alla tradizione – a livello pubblicitario – ma senza
mostrare ai consumatori come realmente avvengono i processi
produttivi e da dove provengono le materie prime utilizzate
per i “sani cibi italiani”.
Il consumatore non sa cosa succeda nell’una e nell’altra parte
della filiera: ad esempio che prodotti di scarsa qualità possano
diventare, grazie al miracoloso e salvifico processo industriale,
un alimento di grande caratteristiche tipiche. Un processo che
vale molto, e che quindi deve costare molto, giustificando così
la vergognosa differenza fra il prezzo alla produzione e quello
alla vendita; un prezzo che il consumatore pagherà con gioia,
sapendo che sono due prodotti ben diversi: quasi pericoloso
il primo, sano sicuro e “naturale” il secondo. Lo sanno, i
consumatori, come viene ottenuto il grano della pasta? Forse sì:
anche qui si insinuano sospetti, si mostrano grandi macchine
e oleografici quadretti di figuranti che fingono di mietere,
cercando di far passare il messaggio che la nostra pasta non
ha nulla a che vedere con l’agricoltura “industriale”, ma è una
produzione “tipica”, realizzata con cura casalinga e ottenuta
da prodotti “fatti a mano”. In fondo, il concetto di “hand
made” è sempre stato il motivo dominante per valorizzare
qualsiasi prodotto industriale, dalla moda all’automobile: ma
il consumatore viene informato su quanto potrà mai essere
stato pagato colui che ha dedicato una giornata di lavoro ad
un oggetto da pochi euro (di norma accade nei Paesi in via di
sviluppo)? Potrà forse godere delle stesse tutele e degli stessi
diritti civili del cittadino che lo acquista?
Almeno a parole, nel resto dell’Unione europea si pone
qualche attenzione alla compatibilità sociale dei prodotti,
alimentari e non; da noi non sembra che se ne interessi
nemmeno la politica, che pure dovrebbe guidare i cittadini
ad essere consapevoli nelle scelte individuali, e coerenti
con i principi costituzionali. Se torniamo all’agricoltura, è
evidente l’interesse a mostrare la totale sicurezza dei processi
di trasformazione alimentare, garantita da norme sanitarie
precise e stringenti. Ma questo interesse non deve andare
a demonizzare la produzione agricola primaria, anch’essa
soggetta a rigide disposizioni ed adeguati controlli sulla
sanità e salubrità dei prodotti agricoli, qualunque sia la loro
destinazione finale.
Un cereale contaminato da micotossine non deve entrare
nella filiera alimentare e mangimistica, e questo è logico; ma
è meno logico che i prodotti da agricoltura biologica siano
percepiti come assolutamente sani, pur contenendo anch’essi
micotossine come, e forse più, di quelli ottenuti dall’agricoltura
convenzionale. In un ambiente ormai gravemente inquinato,
soprattutto dai processi industriali e da un abuso dei mezzi di
trasporto individuali, l’opinione pubblica si attacca al settore
produttivo più debole, anche nei numeri, dimenticando che
l’attività agricola è l’unica a consumare più anidride carbonica
di quanta ne produce.
Le recenti prese di posizione sul glifosate sono un esempio
di questa visione superstiziosa della chimica applicata: il
glifosate è una molecola che viene rapidamente demolita
dall’attività batterica del terreno agrario e che, di fatto,
non può finire nelle acque superficiali e profonde se usata
secondo le regole. Gli agricoltori e i contoterzisti, che usano
il prodotto quotidianamente e ne conoscono le dinamiche,
sono fortemente preoccupati da questa campagna mediatica,
che potrebbe rendere inapplicabili proprio quelle tecniche di
coltivazione (agricoltura conservativa) che hanno un minore
impatto ambientale. Forse non è un caso che il glifosate non
sia più coperto da brevetto industriale e che possa venire
prodotto anche al di fuori delle grandi multinazionali della
chimica; ma l’ipotesi di messa al bando del formulato giustifica
sempre di più i timori di un controllo occulto sull’opinione
pubblica, che può essere indirizzata a piacimento anche
nell’era dell’informazione, o meglio della disinformazione.
Sarebbe poi interessante sapere se, nell’ipotetico caso in cui
ne fosse vietato l’impiego in Europa, la stessa Unione europea
sarà poi in grado di bloccare alle frontiere le derrate alimentari
provenienti dai Paesi dove il glifosate – e altri prodotti ben più
pericolosi per la salute umana, da tempo proibiti in Europa –
sono ancora allegramente impiegati.
Abbiamo più di un motivo per ritenere che ciò non accadrà:
continueremo a vietare a casa nostra e a importare materie
prime contaminate, prodotte fuori dall’Europa, come abbiamo
potuto constatare con gli organismi geneticamente modificati
(soia, mais e pomodoro), che si continua a importare e ad
impiegare nell’industria alimentare: chissà se i consumatori lo
sanno?